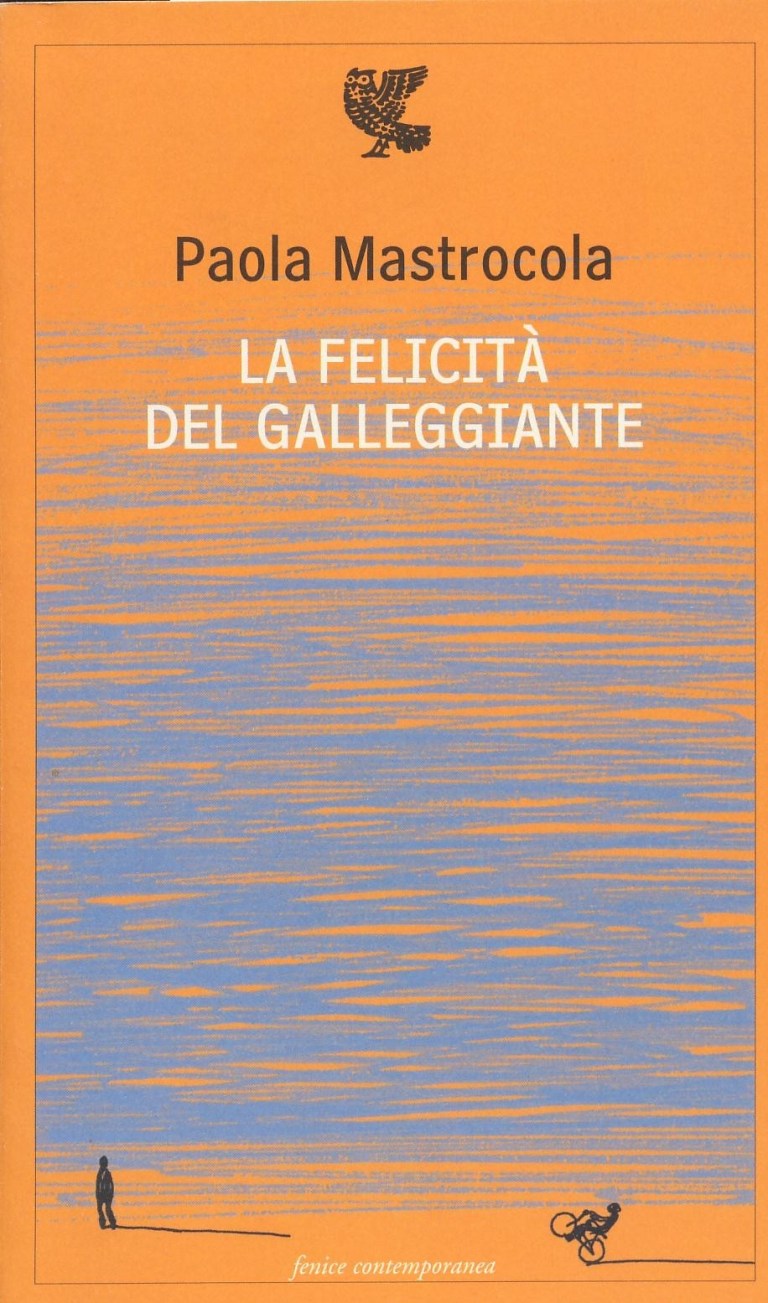La felicità del galleggiante è un libro di poesie di Paola Mastrocola uscito nel 2010 per Guanda. Leggo nella presentazione che dopo una lunga e felice stagione dedicata ai romanzi, questa raccolta segna il sorprendente ritorno di Paola Mastrocola alla poesia. Non che manchi, per esempio, quella curiosità verso i giovani che ha sempre caratterizzato i suoi libri, e qua e là un rapido apparire, sempre più metaforico, di animali. Tuttavia, il ventaglio tematico delle poesie risulta assai più ampio: da queste pagine emergono liriche d’amore e di meditazione, di nostalgia e di esortazione, in un dettato attento alla grande lezione di Orazio. È l’idea di una vita contemplativa che provocatoriamente, alla maniera dell’otium degli antichi, osi contrapporsi al caotico e molteplice dell’oggi, e imprevedibilmente lo vinca. È la continua, persuasiva e anche un po’ ribelle tentazione a lasciar cadere, stare a guardare, non fare. Un caparbio tenersi in disparte e percorrere «viottoli» anziché autostrade.
Credo che non potrei dire di meglio, o altro, di queste poesie. Se non che si sente fortissimo il tenore della prosa, del romanzo, pur con qualche spina di poesia che non dispiace. Belli infatti versi Ora gli amanti parlano / e a un soffio dalle scapole / lui le corre sul filo della schiena, / si ferma a un palmo / dalla nuca e infila / le dita nei capelli / neri / folti. / Si perde. / E quando gli riemergono / le dita così bianche / così fredde / annunciano la prossima stazione o anche solo Abbiamo senza dirlo passato anni. / Come fossero un barlume di scintilla che mi riportano alla mente il (pur in altra levatura) Zagajewski di Adoro osservare il volto di mia moglie.
Il problema di questi versi (questi e non solo questi) resta sempre la definizione del confine tra prosa e poesia, tra costruzione e ispirazione (devo infatti ammettere che quel solo succitato verso di Zagajewski, pur semplicissimo, mi pare di molto superiore a tanta Mastrocola, pur brava). Immagino che quando una parola porta in seno il peso di una vera idea, di un vero sentimento, di una vera ispirazione (leggasi capacità di vedere le cose oltre il visibile) anche se questa parola è banale diventa imponente, bellissima.
Al bar del porto con gli occhiali a specchio
Siediti al portico, guarda il mare.
Guarda
come le navi che all’imboccatura
arrestano il corso
armeggiano nell’onde,
spumeggiano ai motori
che ingrassano di olio il porto
e poi più nulla, un lago che si quieta
in fetida pastura.
Niente che parta o arrivi,
niente da dire, fare. Guarda.
Niente da aspettare.
Diventa occhio che s’allarga e comprende,
lascialo planare.
Dimentichiamo i gesti
utili
che innescano la serie di altri gesti:
non facciamo rumore.
Neanche sia il tintinnio d’un bicchiere:
che se gli batti le chiavi contro
ecco, s’appresta il cameriere
a ripulire il tavolo dei resti…
Restami tu, riflettimi
inutilmente il mare,
l’immagine di me mentre sonnecchio
– ridotta a una misura circolare –
nel vortice dei tuoi occhiali a specchio.
Giorni felici
Ci sono giorni felici
dove s’è fatto il nulla,
un mare caldo buono
dove non c’è nessuno e il mondo
è un fragile contratto spazio
cavo, una conchiglia
col rumore dentro franto, d’altro,
d’onde: mare
di tempesta o calmo
poco fa. Poco è
in questo tempo che invece di passare
resta.
Ci sono giorni felici
che il pensiero è in festa,
pensa senza pensare,
signore domina la mente, allarga
così che prende
intorno e l’universo
s’espande, mette ali,
copre d’un velame i volti,
i ruoli,
anche gli amici che poi
non sono mai tali.
Talamone
Con quanta leggerezza cambiamo treno,
orari, giorno, destinazione.
Pensiamo poco al caso.
Al fatto che ogni strada ha un senso,
quella che ci porta nel burrone
e l’altra a prendere pigramente il sole.
(Amanti
si palpano le mani in treno
davanti a me
ticchettano col dito all’orlo
del ginocchio,
percorrono la gamba appena in su.)
Viaggi, rincorse.
Due ore fa ed ero
convinta di restare.
Poi la repentina voglia di partenza
per togliermi
il pensiero di te.
Anticipo il ritorno, parto
prima che si risollevi un lembo
del velo.
(Ora gli amanti parlano
e a un soffio dalle scapole
lui le corre sul filo della schiena,
si ferma a un palmo
dalla nuca e infila
le dita nei capelli
neri
folti.
Si perde.
E quando gli riemergono
le dita così bianche
così fredde
annunciano la prossima stazione.)
Fine. Scendiamo a Talamone?
La scrittura è una talpa scura
La scrittura è una talpa scura,
l’animale senza gli occhi
che scava con le unghie il buio.
La scrittura è non avere paura
di ferire
gli altri,
di morire.
Stare seduti con la testa china,
la testa che si curva
ad arco e sta.
Non fare movimenti, non vedere
città.
Avere l’aria assorta,
lo sguardo che non guarda,
la voce che non parla.
Abitare un’altra vita, storta,
senza pietà.
Tra noi simili
Eppure andiamo per una strada certa.
La biro in tasca, i versi ai bordi
del giornale quotidiano
in quest’aria da vacanza deserta.
Così ci salutiamo tra noi simili
passeggiando per i borghi vecchi
liguri;
e intorno un vortice di rami secchi
e foglie, ciottoli, granaglie
che rotolano a valle
laggiù dove dal muro
si vede tramontare.
L’insegnante vecchia
Arriva un’insegnante vecchia
in biblioteca
gli occhiali spessi e in mano
un sacchetto di plastica incolore
col mazzo delle chiavi, il fazzoletto.
S’aggira per i libri, esplora,
avvicina
la lente al titolo dei libri,
indugia, se ne va.
Cos’ha studiato a fare, penso,
che cosa se ne fa
di tutti i libri che sa,
se non li ha ancora fatti
sparire dentro
perchè ne esca
qualche lezione di umiltà.
E come pensa di restare
oltre la vita che se ne va.
Elogio dell’ufficio
Un luogo dove stare, essere
ospite, abitare
fuggiasco, viaggiatore.
Dove tenere in ordine le carte,
il mazzo delle biro, il temperino.
Collocare la foto del bambino
quando giocava col trattore.
Un luogo dove essere in orario
e timbrare.
Dover essere, fare
le cose che bisogna fare e poi andare
serenamente a perdersi in un tempo
libero restante, un vuoto
permanente assente.
Il sogno di una cosa fatta,
il compito eseguito,
l’impresa, l’opera
che si conclude al suo inizio: esatta.
Un luogo dove lavorare
ma ogni tanto guardare,
mandare l’occhio alla finestra, astratto.
Un buco anfratto dove stare
nascosto, protetto: un posto
come un altro, luogo
che ti lega ma ti lascia
libero, numero,
la sigla della tua mansione,
semplicemente una funzione.
Uno dei tanti, inesistente.
La gioia che non siamo
niente.
L’amore non detto
Mai parlato, amore, del mio amore.
Amore del non detto,
amore mio mai detto
neanche in sogno o sui gradini
stancanti di quell’ara coeli a Roma che mi manca
– ma quali cieli, e quale ara –
besco che s’offusca
sul nostro indesiderio sfranto…
Ma ti ho riversato
i fiumi-fumi di parole accese,
il fuoco di passione
ardente
– che come avrebbe arso
per il tortuoso corso
degli ultimi trent’anni?
E quale fiume adesso in quale acqua
ci vorticherebbe, e in quale fumo
noi irrespiranti?
Amore giovane ventenne coltivato
in serra
e chiuso come scrigno dei tesori,
amore-gioia
gioiello,
cresciuto al giro del mio chiostro
a quel vento quadrato di silenzio…
Grazie del silenzio, amore che avrei perso
a furia di parole.
È così per tutto
il breve attimo del soffio:
avremmo consumato
il gelo in acqua, la legna nel camino,
il trave con i tarli, la vita con i figli,
l’asilo, la madrina…
le fisime infinite d’una storia
abbrustolita e subito
carbonizzata carne
alla griglia.
Invece io così ti ho preservato.
Vedi che non s’assottiglia
la lamina al ricordo.
Mi giaci intatto nell’anfratto
protetto della mente, senza uscita
o mio per sempre la prima volta pensato.
Ci protegge il mancato
seguito, l’inizio intentato.
Sei diventato
la pellicola che non si svolge,
la barca che non stacca terra,
il blocco
che fa rigide le ruote.
Così mi resti
il film ancora da vedere,
la storia ferma all’incipit,
il viaggio rimandato all’infinito
(Lisbona, la città che sogno di vedere…),
il libro che ti lasci ultimo e segretamente
speri che non leggerai.
Questo voglio: essere
la vita che non hai.
Le montagne sono beige
Gli steccati di legno stinto
sono beige,
i prati d’erbapaglia cotti
da un sole troppo basso, troppo avvinto
alle cose di quaggiù
sono beige, i rami
rotti,
i passaggi non asfaltati
dove ogni ruota alza polvere
che offende l’aria, come il mare
secoli fa la nave
d’Argo.
Le montagne sono beige,
di questo non colore, fine
rarefatto. Assente.
Un grigio compromesso col giallino,
marrone chiaro e poco nero,
uno sbaffo sfocato sui contorni
che si sfuma
in bruma.
Tutto in montagna è beige,
persino i pini folti
che ricoprono la roccia di pelliccia
irta, i molti aghi: sono di un verde beige,
non osano di più.
Eppure che durezza
emana dalla pietra beige!
Quale coraggio e adamantino sfoggio
di longevità
come a dire: ebbene?
Noi che da millenni poggiamo qua.
Perciò
ho messo in casa un tappeto beige,
un divano beige, i quadri
beige, i piatti beige déco.
Ho dipinto le finestre e i muri
di beige, e la ringhiera del balcone.
Io, che amo il blu…
così, per ammirazione.
Come segno di ulteriore stima
smodata, mai ripagata.
Color montagna, non una nuance
in più…
Io che amo il blu
mi sono fatta una casa beige
non colorata, écru…
la copia della pietra che resiste
al tempo, roccia, ferma
intatta, inneggia
a una mancata nostra eternità.
Inventare
Collocheremo un’aquila all’ingresso
in questa nuova casa di montagna.
La collocheremo colle ali
bene tese, e late
ad occupare il cielo, e il becco
giallo, ricurvo com’è dell’aquile
o come il naso delle streghe adunco
che ci fa paura
che ci fa cucù dai libri
figurati e dalle notti insonni.
Collocheremo un’aquila perchè ci va
di fare il nido in alto
dove ghiacciano le cime e s’ode
solo
l’ululo lugubre del vento
(e perchè ci piace dire s’ode
e non si sente,
e ci piacciono le cose kitsch e pacchiane
ma col significato chiaro, e buono)
e dove c’è la notte bruna come gli orsi
bruni e buoni
che fa la neve cupa e il bianco
blu.
Collocheremo un’aquila perchè tu
non la vedresti mai
volare intorno ai vetri della casa.
Così, te la farò di carta
o creta o cera,
perchè si fa così quando ti manca
una persona cara:
coltivi la sua assenza,
fai la statua,
la voce registrata sull’ultimo cd,
la foto incorniciata con la scritta
«You and Me»…
Collocheremo l’aquila
finta perchè ci fa montagna
o perchè la vita è finta.
Perchè noi due siamo così;
disegnatori di pensieri
che diventano veri.
(Ricordi quando disegnammo un figlio
che fa i compiti sul prato,
e il cane accanto accoccolato,
e il figlio sereno biondo finto
accigliato?)
Così la nostra aquila inventata
volteggerà davvero al vento:
il vento della parola invento
vuol dire che sarai
– nel quadro dei pensieri, nella foto,
nella nostra nuova casa o nel passato –
con me volante
aquila in vento.
Il conto dei camini accesi
Il cielo è un velo rosato
che si abbassa sulle case questa sera.
Ti parlo. C’era
un camino con il fuoco a mezzo, ambrato.
Un’ombra di calore, e prima
le tue mani che portavano la legna,
tutt’intorno uno sbriciolio di rami,
una secchezza morta che trovava lì
la fine.
Abbiamo senza dirlo passato anni.
Come fossero un barlume di scintilla.
E accanto
le rovine che non abbiamo visto,
gli animali e ululi
feroci e spari, crolli
fuori
dall’invisibile recinto
delle nostre risa,
allegra
resa.
Ci siamo fatti in questi anni un cono
di luce accesa,
e in quell’accecamento buono
– mentre la legna finiva di bruciare –
ci siamo
consolati di passare.